Lifestyle
Educazione affettiva a scuola: la Campania apre la strada a una legge nazionale
Sessualità, parità di genere, salute riproduttiva e prevenzione della violenza entrano nei programmi didattici: un passo avanti verso una scuola che forma cittadini consapevoli, non solo studenti.
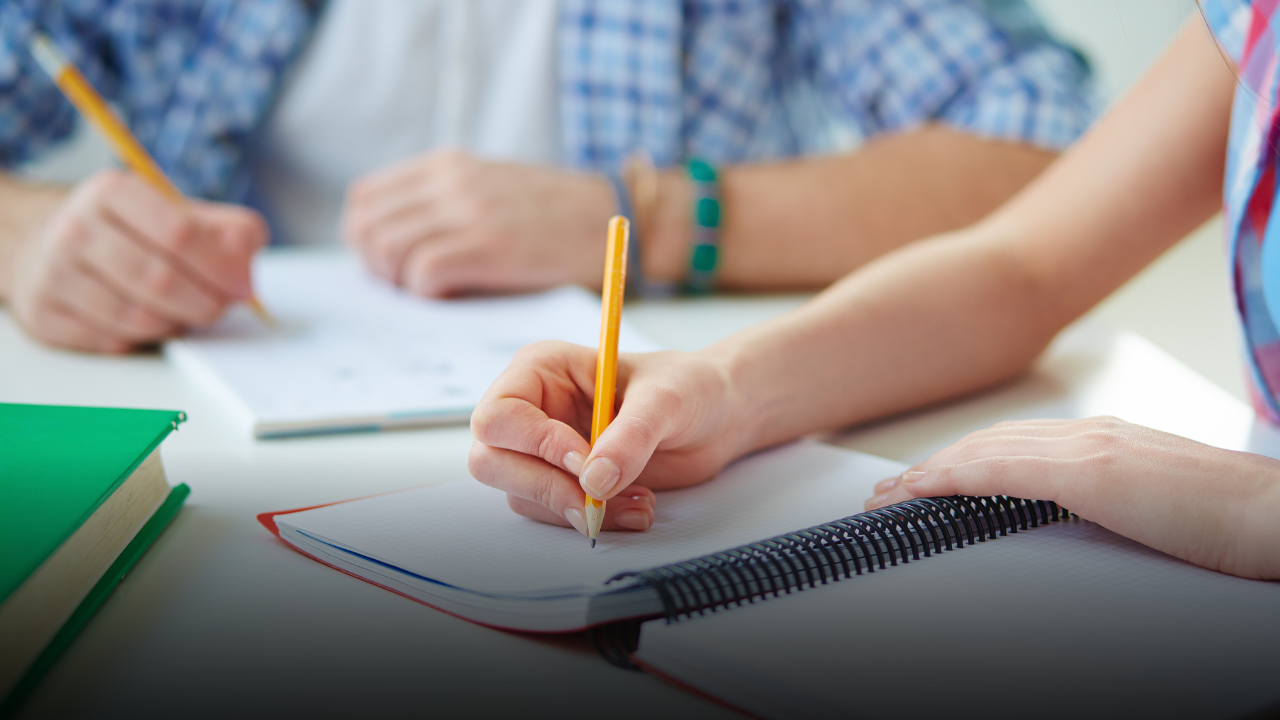
Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità una proposta di legge che potrebbe segnare una svolta nel panorama educativo italiano: introdurre stabilmente l’educazione affettiva e relazionale nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il testo, ora inviato alla Camera dei Deputati, propone di inserire nei percorsi didattici temi come la sessualità consapevole, la salute riproduttiva, l’uguaglianza di genere e la prevenzione della violenza.
Un’iniziativa che tocca un terreno complesso, dove per anni si sono incrociati dibattiti ideologici, timori dei genitori e richieste del mondo educativo. Ma questa volta, la Campania sceglie un approccio diverso: non progetti temporanei o facoltativi, bensì un’integrazione strutturale e permanente all’interno dei programmi scolastici.
Una legge articolata e concreta
La proposta si compone di quattro articoli principali, accompagnati da un impegno esplicito sulla formazione del personale docente.
- L’articolo 1 introduce moduli specifici di educazione all’affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, calibrati in base all’età e al grado di maturità psicofisica degli studenti.
- L’articolo 2 affida al Ministero dell’Istruzione e del Merito il compito di elaborare, entro 120 giorni, linee guida nazionali, previa consultazione pubblica, per garantire pluralismo culturale e trasparenza.
- L’articolo 3 stabilisce che ogni scuola inserisca un piano triennale per l’educazione affettiva e al rispetto delle differenze nel proprio PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).
- L’articolo 4 prevede informazioni chiare e accessibili per le famiglie riguardo ai contenuti e alle modalità dei percorsi educativi.
Il testo prevede inoltre che i docenti ricevano formazione specifica su affettività, sessualità, contrasto alla violenza e alle discriminazioni, affinché i contenuti siano trattati con competenza e sensibilità.
Oltre la norma: una sfida culturale
La proposta, nata a livello regionale, è ora all’esame della Commissione Cultura della Camera. Se approvata, diventerebbe una delle prime leggi in Italia a sancire per legge l’obbligatorietà dell’educazione affettiva.
Un cambiamento non solo normativo, ma culturale. L’obiettivo è riconoscere alla scuola un ruolo attivo nella formazione relazionale delle nuove generazioni: insegnare il rispetto reciproco, la gestione delle emozioni, la consapevolezza del proprio corpo e dei propri limiti.
Gli esperti sottolineano che tali percorsi possono contribuire a ridurre fenomeni di bullismo, discriminazione e violenza di genere, oggi in crescita tra gli adolescenti. Secondo dati ISTAT e Save the Children, circa un ragazzo su quattro dichiara di aver assistito a episodi di violenza verbale o fisica in ambito scolastico, e oltre il 50% delle ragazze tra i 14 e i 18 anni riferisce di aver subito commenti sessisti o molestie online.
Un dibattito aperto
Come ogni tema che tocca l’educazione, anche questo divide. C’è chi teme che parlare di sessualità e affettività a scuola significhi “sottrarre” alle famiglie un ruolo educativo primario. Ma la legge campana, con la sua attenzione al coinvolgimento dei genitori e al rispetto dell’età degli alunni, punta a costruire un dialogo condiviso e non a sostituire i valori familiari.
“Educare all’affettività non significa parlare di sesso, ma insegnare il rispetto e la consapevolezza delle proprie emozioni,” ha sottolineato uno dei promotori del testo. “È una forma di prevenzione culturale contro la violenza e le discriminazioni.”
Il futuro dell’educazione relazionale
Se la proposta dovesse superare l’esame parlamentare, potrebbe diventare un modello per altre regioni e un punto di svolta per la scuola italiana, che da anni chiede strumenti per affrontare con competenza i temi dell’emotività, della parità e della convivenza.
In un momento in cui crescono i casi di violenza giovanile e disagio psicologico tra gli adolescenti, l’educazione affettiva appare non più come un optional, ma come un bisogno educativo primario.
Perché imparare a conoscere se stessi e gli altri, in fondo, è la base per ogni forma di società civile.
INSTAGRAM.COM/LACITYMAG
Società
Deconcentrati, stressati, ansiosi. I nostri adolescenti sono a rischio
Non dormono, non si concentrano, stanno poco in società: così lo smartphone ha reso depressi e ansiosi i nostri adolescenti.

Il libro “La generazione ansiosa” di Jonathan Haidt (Rizzoli editore) ha posto una questione importante. Qual è l’impatto degli smartphone e dei social media sul benessere mentale degli adolescenti. L’autore ha presentato un quadro preoccupante, supportato da dati molto inquietanti. L’uso eccessivo degli smartphone ha portato a un aumento della depressione, ansia e dei suicidi tra i giovani. La “Grande riconfigurazione dell’infanzia“, come la definisce Haidt, ha spostato i ragazzi dal gioco libero all’isolamento digitale, privandoli delle esperienze sociali fondamentali per il loro sviluppo emotivo e mentale.
Come i social stanno rovinando i nostri figli
L’autore sostiene che l’abuso dello smartphone, combinato con l’iperprotettività dei genitori, ha creato una generazione più vulnerabile, costantemente in modalità di difesa, incapace di affrontare rischi e frustrazioni. I bambini di oggi sono meno preparati a gestire le sfide della vita perché sono stati protetti eccessivamente dai noi genitori esposti senza controllo ai pericoli della rete. Questa combinazione ha reso gli adolescenti più fragili e ansiosi.
Ci si incontra meno e in fretta
Uno degli effetti più gravi dell’uso degli smartphone è la riduzione delle interazioni sociali reali. I ragazzi passano meno tempo con gli amici e più tempo online, perdendo le opportunità di sviluppare relazioni profonde e significative. Inoltre, la frammentazione dell’attenzione e la dipendenza da notifiche continue minano la loro capacità di concentrazione e di riflessione.
La tecnologia non va demonizzata, va usata meglio
Haidt non è un luddista, non demonizza la tecnologia in sé, ma invita a una riflessione critica sul modo in cui la usiamo. È importante, dice, distinguere tra le opportunità offerte dalla rete e le distorsioni create dai social media, che alimentano una visione binaria e semplificata del mondo. Le soluzioni, secondo lui, non risiedono nel rifiuto della tecnologia, ma nell’educazione e nella regolamentazione del suo uso.
Serve una riconnessione con la realtà
Il libro si chiude con consigli pratici per genitori, insegnanti e governi su come affrontare questi problemi. Haidt suggerisce una discussione aperta tra genitori e figli, e un uso più consapevole degli smartphone, spegnendoli quando necessario per riconnettersi con la realtà e tra di loro.
Tech
Vita, morte e notifiche push: perché la tecnologia ci segue anche in bagno
Dal letto al water, passando per la scrivania e la metro: ormai il telefono è il nostro compagno inseparabile. Ma a che prezzo? La tecnologia ci semplifica la vita o ci sta rubando il silenzio? Una riflessione semiseria sull’uso (e l’abuso) degli schermi che ci guardano mentre li guardiamo.

C’è stato un tempo in cui il bagno era l’unico vero rifugio della giornata. Un luogo sacro, privato, al massimo profanato da una rivista sgualcita o da un catalogo dell’IKEA. Oggi? Oggi entriamo e ci portiamo dietro l’intero internet.
La tecnologia ci accompagna ovunque: a tavola, a letto, al lavoro, in vacanza e sì, anche lì. Siamo diventati incapaci di stare senza uno schermo acceso. Ci svegliamo e scrolliamo, cuciniamo con TikTok, camminiamo con Google Maps e ci addormentiamo con Netflix. Se il telefono è scarico, l’ansia sale più di uno spread in piena crisi finanziaria.
Ma non era questo il futuro che ci avevano promesso? Dove sono le macchine volanti? I robot che ti fanno il caffè? Gli ologrammi amici? Al loro posto abbiamo la notifica che “oggi hai usato Instagram per 2 ore e 48 minuti” e lo smartwatch che ti chiede se “vuoi fare una pausa per respirare”. Con il dettaglio che, se ti rifiuti, ti guarda male. Letteralmente.
Il problema non è la tecnologia in sé. Anzi, benedetti siano gli assistenti vocali che ti ricordano dove hai lasciato le chiavi o i frigoriferi smart che ti avvisano quando scade il latte. Il problema è che siamo diventati allergici al vuoto, al silenzio, all’assenza di stimoli. Ogni momento libero è un’occasione per rimetterci le cuffiette, aprire un’app, ascoltare un podcast, mandare un vocale di 3 minuti che poteva essere un messaggio di 4 parole.
I social ci fanno credere di essere connessi con tutti, mentre nella realtà ci stanno disconnettendo da tutto. Anche da noi stessi. Perché non è normale sentirsi persi se il telefono resta in un’altra stanza. Non è normale mangiare senza parlare, solo per filmare il piatto perfetto da postare. E non è normale rispondere alle mail mentre sei ancora in pigiama e non sai neanche in che giorno vivi.
La verità è che la tecnologia dovrebbe semplificarci la vita, non consumarla. Dovrebbe essere uno strumento, non un’ossessione. Dovremmo imparare a spegnerla ogni tanto, senza sentirci in colpa o disconnessi dal mondo.
Forse dovremmo tornare a leggere libri cartacei, a perdere tempo guardando fuori dalla finestra, a dimenticare il telefono a casa e non viverla come una tragedia epocale. Forse dovremmo farci un regalo: una giornata offline.
E se proprio non riusciamo, almeno lasciamo fuori il telefono dalla porta del bagno. Per rispetto. Non nostro, ma del bidet.
Società
Il gioco perduto: bambini chiusi in casa tra schermi e tecnologia
Tra smartphone, videogiochi e tv, i bambini stanno abbandonando il gioco all’aperto, perdendo occasioni di socializzazione e sviluppo. Il governo britannico corre ai ripari con una “strategia nazionale del gioco”, obbligando le scuole a garantire momenti di svago all’aperto. Riuscirà questa misura a contrastare l’isolamento digitale delle nuove generazioni?

Negli ultimi anni, il tempo che i bambini trascorrono all’aperto è diminuito drasticamente, sostituito da ore passate davanti agli schermi di smartphone, tablet, televisori e videogiochi. Questo fenomeno, che ha radici profonde nell’evoluzione tecnologica e sociale, ha portato molti governi a interrogarsi sul futuro delle nuove generazioni e sugli effetti di questa abitudine sulla loro crescita. Il Regno Unito ha deciso di intervenire con una proposta concreta: introdurre una strategia nazionale del gioco, affinché le scuole garantiscano attività all’aperto durante le pause e incoraggino i bambini a riscoprire il piacere del gioco fisico e della socializzazione diretta.
In passato, il gioco per strada era una parte fondamentale dell’infanzia
Le generazioni più anziane ricordano con nostalgia le giornate passate nei parchi, nei cortili e nelle piazze, esplorando il mondo e costruendo relazioni attraverso il movimento e l’interazione reale. Oggi, invece, solo uno su quattro dei bambini dice di giocare all’aperto con una certa regolarità. Il resto della loro quotidianità si svolge principalmente al chiuso, tra attività scolastiche e tempo libero gestito attraverso dispositivi elettronici. Questo cambiamento ha portato conseguenze significative. Una maggiore sedentarietà, una riduzione delle capacità motorie e un impatto negativo sulle abilità sociali, poiché la comunicazione attraverso uno schermo non sostituisce il valore dell’interazione diretta.
Bambini troppo protetti mentre la società peggiora
Uno dei fattori che ha contribuito a questa trasformazione è l’iper-protezione dei genitori, che rispetto al passato tendono a essere più apprensivi e meno disposti a lasciare i figli esplorare autonomamente. La paura di pericoli, incidenti o incontri indesiderati ha reso le famiglie più diffidenti verso il gioco libero all’aperto. Inoltre, l’aumento del traffico nelle città ha ridotto gli spazi sicuri dove i bambini possono giocare senza rischi.
Quella tecnologia che chiude gli orizzonti invece che aprirli
Ma il principale motore di questo cambiamento rimane la tecnologia. Smartphone e videogiochi offrono intrattenimento immediato e coinvolgente, creando dipendenza e sostituendo esperienze di gioco più fisiche e dinamiche. I social media e le piattaforme di streaming rendono ancora più allettante stare in casa, costruendo un ambiente in cui tutto è accessibile senza dover uscire. Per molti bambini, l’esplorazione del mondo avviene attraverso lo schermo e non attraverso l’esperienza diretta.
Le conseguenze? Obesità, poco concentrazione e difficltà a esprimere emozioni
Le conseguenze di questo fenomeno sono ormai visibili: l’aumento dell’obesità infantile, difficoltà nella gestione delle emozioni, minore capacità di concentrazione e problemi nel relazionarsi faccia a faccia con gli altri. Alcuni studi hanno evidenziato che il gioco all’aperto aiuta a sviluppare la creatività, la capacità di risolvere problemi e l’empatia, mentre l’isolamento digitale porta spesso a forme di ansia e insicurezza.
Bambini: tutti fuori all’aria aperta…
Per questo il governo britannico sta cercando di invertire la tendenza con un intervento legislativo che garantisca ai bambini il diritto alla ricreazione. In Scozia e in Galles questa disposizione è già in vigore, mentre in Inghilterra si punta a renderla obbligatoria, affinché tutte le scuole offrano opportunità di gioco all’aperto durante l’intervallo. Si tratta di una misura che potrebbe migliorare la salute fisica e mentale dei bambini, riportando nelle loro vite il valore dell’esplorazione e del gioco libero.
-

 Gossip2 anni fa
Gossip2 anni faElisabetta Canalis, che Sex bomb! è suo il primo topless del 2024 (GALLERY SENZA CENSURA!)
-

 Sex and La City2 anni fa
Sex and La City2 anni faDick Rating: che voto mi dai se te lo posto?
-

 Cronaca Nera2 anni fa
Cronaca Nera2 anni faBossetti è innocente? Ecco tutti i lati deboli dell’accusa
-

 Speciale Grande Fratello1 anno fa
Speciale Grande Fratello1 anno faHelena Prestes, chi è la concorrente vip del Grande Fratello? Età, carriera, vita privata e curiosità
-

 Gossip2 anni fa
Gossip2 anni faLa De Filippi beccata con lui: la strana coppia a cavallo si rilassa in vacanza
-

 Speciale Olimpiadi 20242 anni fa
Speciale Olimpiadi 20242 anni faFact checking su Imane Khelif, la pugile al centro delle polemiche. Davvero è trans?
-

 Video12 mesi fa
Video12 mesi faVideo scandalo a Temptation Island Spagna: lei fa sesso con un tentatore, lui impazzisce in diretta
-

 Speciale Grande Fratello1 anno fa
Speciale Grande Fratello1 anno faShaila del Grande Fratello: balzi da “Gatta” nei programmi Mediaset



































