Cronaca Nera
Mostro di Firenze, la verità nel sangue: il Dna di Natalino riapre la pista sarda
Un esame del Dna compiuto a 56 anni di distanza riscrive le origini del primo delitto di Signa, quello da cui tutto è cominciato. Natalino, il bambino di sei anni sopravvissuto alla strage, è figlio del maggiore dei Vinci. La procura ha notificato l’esito al diretto interessato, che non ha mai conosciuto l’uomo. Ma ora, il clan sardo torna prepotentemente in scena.
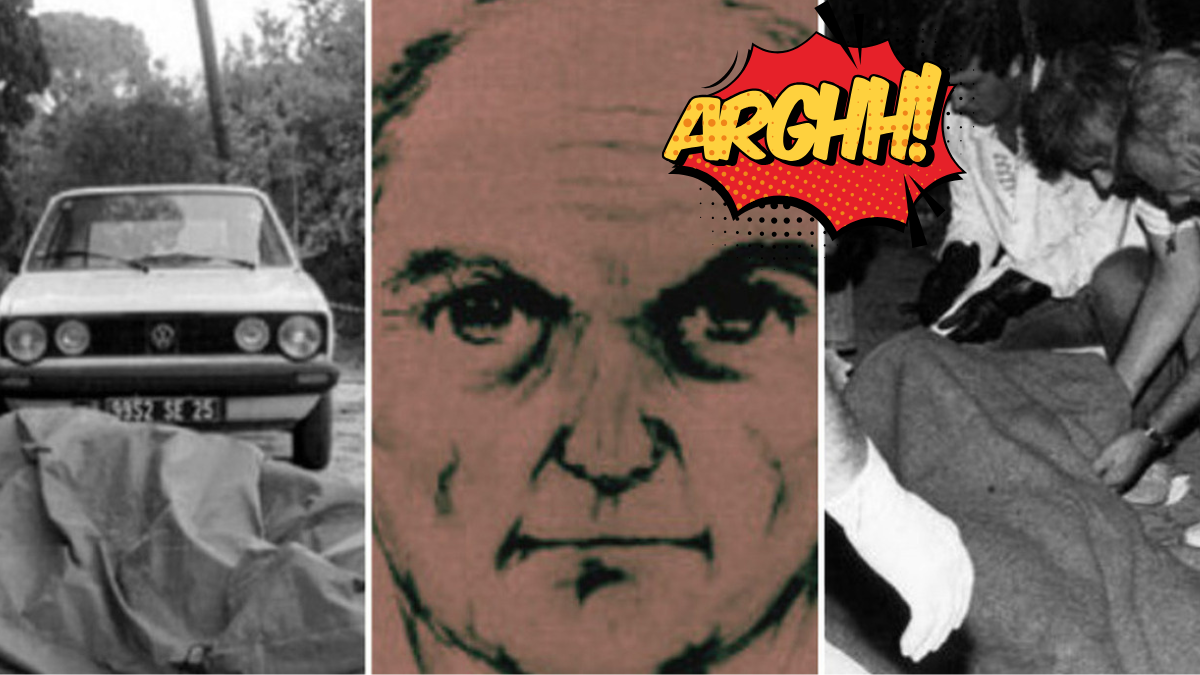
Ci sono casi che non muoiono mai. Si addormentano, sembrano svanire nell’archivio della memoria collettiva, e poi riemergono. Basta un dettaglio. Una prova. Una goccia di sangue che racconta un’altra storia. Come nel caso del Mostro di Firenze, dove ogni certezza è provvisoria, ogni verità è una mezza verità. E ogni tanto, come adesso, arriva qualcosa che manda tutto in pezzi.
Questa volta è il Dna. Un accertamento genetico disposto dalla procura ha stabilito che Natalino Mele, il bambino di sei anni e mezzo che nel 1968 scampò a un duplice omicidio a Signa, non è figlio di Stefano Mele, il manovale condannato in via definitiva per l’omicidio della moglie, Barbara Locci, e del suo amante, Antonio Lo Bianco. Il padre biologico di Natalino è Giovanni Vinci, fratello maggiore di Francesco e Salvatore, i due sardi per anni sospettati, arrestati, rilasciati, indicati come possibili membri del famigerato “clan” che avrebbe dato origine alla catena di sangue che terrorizzò la Toscana fino al 1985.
Ma Giovanni no. Lui è sempre rimasto ai margini. Mai un avviso di garanzia, mai un interrogatorio, mai una convocazione. E invece era l’amante della Locci. Era il padre di quel bambino. Era, forse, più dentro di quanto chiunque abbia mai sospettato.
La scoperta è stata notificata nei giorni scorsi proprio a Natalino. Che oggi è un uomo, e che, raggiunto dai giornalisti, ha detto con onestà disarmante: «Non l’ho mai conosciuto. Non so chi sia». La scoperta arriva grazie al lavoro del genetista Ugo Ricci, esperto di cold case già noto per il suo ruolo nell’indagine sul delitto di Garlasco.
Ora, la domanda torna, più inquietante che mai: chi ha risparmiato quel bambino? E perché?
Quella notte del 21 agosto 1968, Natalino fu trovato ore dopo l’omicidio in un casolare a due chilometri dalla scena del crimine, con i calzini puliti e nessuna traccia di fango o sangue addosso. Disse di essersi svegliato al buio e di aver camminato. Ma oggi quell’immagine, già fragile, sembra crollare del tutto.
Forse qualcuno lo portò lì, forse lo conosceva, forse sapeva di chi era figlio, forse non volle ucciderlo per un motivo preciso. Forse.
Perché ora, con la conferma che Stefano Mele non era il padre biologico del bambino, tutto quel castello crolla. Mele fu accusato, condannato, dichiarato inaffidabile, e per questo anche scagionato in parte. Ma oggi si scopre che non era nemmeno il padre del piccolo. E quindi? Era davvero lui il carnefice? O un capro espiatorio, sacrificato in nome di qualcosa di più grande?
La pista sarda, a questo punto, non è più un’ipotesi. È un ritorno. Un riavvolgere il nastro fino al principio. Francesco e Salvatore Vinci, già nel mirino degli inquirenti, erano amanti abituali della Locci. La donna, affascinante, inquieta, e ben nota in paese, era al centro di un piccolo universo di uomini che la desideravano e la possedevano. Giovanni, ora si scopre, era uno di loro. Il primo. Forse il più vicino.
E l’arma? Quella Beretta calibro 22 con silenziatore artigianale che uccise Barbara e Antonio? Non fu mai trovata. Ma tornò. Sei anni dopo, nel 1974, con l’omicidio di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini, e poi ancora, sempre con la stessa firma: colpi alla testa, corpi mutilati, una scenografia dell’orrore.
È lecito allora chiedersi: quel primo delitto fu davvero isolato? O fu la prova generale? L’inizio di qualcosa di più grande, feroce, pianificato?
In questa nuova luce, Natalino Mele non è solo la vittima mancata. È il punto zero di una storia che ci riguarda ancora. Perché in lui si incrociano il sangue delle vittime, i silenzi degli assassini, le omissioni di chi non volle vedere.
E se Giovanni Vinci, fino a oggi solo un nome tra tanti, era davvero il padre biologico, allora il mostro aveva un volto più vicino di quanto si sia mai voluto ammettere.
Le indagini proseguono. Ma come sempre, nel caso del Mostro di Firenze, ogni verità porta con sé nuovi dubbi. Ogni certezza si sbriciola sotto i colpi del tempo. E ogni passo avanti sembra riportarci sempre allo stesso punto: a una notte d’estate, a un bambino con i calzini puliti, a due corpi freddi su un sedile d’auto. E a un orrore che non ha ancora finito di parlare.
INSTAGRAM.COM/LACITYMAG
Cronaca Nera
Caso Garlasco, Bruzzone a Quarto Grado: “Ho quasi finito un lavoro sui movimenti di Stasi. Ha detto delle bugie”
Durante Quarto Grado, Roberta Bruzzone rivela di aver quasi concluso uno studio sui movimenti di Alberto Stasi, mettendoli a confronto con le sue versioni. Il lavoro sarà donato alla parte civile, ma in studio Caterina Collovati solleva una domanda chiave.

A proposito del caso di Garlasco, il dibattito torna ad accendersi negli studi di Quarto Grado. Ospite della trasmissione, Roberta Bruzzone ha annunciato di essere ormai vicina alla conclusione di un lavoro di analisi sui movimenti di Alberto Stasi nella mattina del delitto.
Un’analisi che, come spiegato in studio, mette a confronto quei movimenti con le dichiarazioni rese dallo stesso Stasi all’epoca dei fatti.
“Ha detto delle bugie”
La conclusione a cui è arrivata Bruzzone è netta. Secondo quanto dichiarato in trasmissione, dal confronto emergerebbero incongruenze tali da portarla ad affermare che Stasi “abbia detto delle bugie”. Un giudizio che riporta al centro del dibattito uno dei nodi più controversi dell’intera vicenda giudiziaria.
La criminologa ha inoltre precisato che il lavoro, una volta concluso, verrà donato alla parte civile.
La scelta di consegnarlo alla parte civile
La decisione di mettere l’analisi a disposizione della parte civile viene presentata come un contributo tecnico, frutto di uno studio sui dati e sulle dichiarazioni disponibili. Un passaggio che, però, apre immediatamente una nuova discussione sul piano dell’utilità processuale.
La domanda di Caterina Collovati
In studio, Caterina Collovati interviene con una domanda diretta che sposta il fuoco del confronto: a cosa servirebbe questo lavoro, visto che l’indagato oggi è Andrea Sempio?
Un interrogativo che sintetizza il cuore del dibattito: il valore di un’analisi su Stasi in una fase in cui l’attenzione giudiziaria si concentra su un altro nome.
Un confronto che resta aperto
Il botta e risposta in studio fotografa bene lo stato attuale del caso Garlasco: una vicenda che, a distanza di anni, continua a generare analisi, interpretazioni e domande irrisolte. Tra studi tecnici, nuove ipotesi e interrogativi sulla loro ricaduta concreta, il confronto resta aperto, dentro e fuori dalle aule giudiziarie.
Cronaca Nera
Venere in pelliccia in tribunale: Madalina Ghenea affronta l’udienza contro la stalker
Madalina Ghenea compare in tribunale elegante e composta per l’udienza contro la presunta stalker. Chiesto un risarcimento da 5 milioni di euro, mentre la difesa chiede l’assoluzione sostenendo che l’account incriminato non appartenga all’imputata.

C’è chi sceglie il silenzio, chi l’invisibilità. Madalina Ghenea ha scelto la presenza. E lo ha fatto a modo suo. L’attrice e modella romena si è presentata in tribunale per l’udienza del processo contro la donna accusata di averla perseguitata, indossando un look sofisticato, quasi cinematografico, che non è passato inosservato. Accanto a lei, la madre, presenza discreta ma centrale in una vicenda che ha segnato profondamente entrambe.
L’ingresso in aula e la richiesta di risarcimento
Ghenea è comparsa in aula con un outfit scuro, pelliccia e portamento da diva d’altri tempi, una scelta che ha subito acceso il dibattito mediatico. Ma dietro l’immagine c’è un procedimento giudiziario serio e complesso. Il legale dell’attrice ha chiesto un risarcimento di 5 milioni di euro per i danni morali e psicologici subiti, mentre per la madre la richiesta ammonta a 200mila euro, a testimonianza del coinvolgimento diretto e delle conseguenze familiari della vicenda.
Le accuse: messaggi continui e pressione psicologica
Secondo l’accusa, l’attrice sarebbe stata bersaglio di una lunga serie di messaggi ossessivi, invasivi e reiterati, tali da configurare una condotta persecutoria. Una pressione costante che avrebbe inciso sulla serenità personale e professionale di Ghenea, costringendola a cambiare abitudini e a vivere in uno stato di allerta permanente. Un copione purtroppo noto a molte donne esposte pubblicamente.
La difesa: “L’account non era della mia cliente”
Di tutt’altro segno la linea della difesa della presunta stalker. L’avvocato ha chiesto l’assoluzione sostenendo che l’account da cui sarebbero partiti i messaggi non appartiene alla sua assistita. Una tesi che sposta il baricentro del processo sulla prova tecnica e sulla riconducibilità certa delle comunicazioni contestate, nodo centrale dell’intero procedimento.
Il processo entra ora nella sua fase più delicata, mentre l’immagine di Madalina Ghenea in tribunale – elegante, composta, accompagnata dalla madre – resta come simbolo di una battaglia che va oltre l’estetica e riguarda il diritto di non essere perseguitate, neppure quando si è una diva.
Cronaca Nera
Garlasco, il colpo di scena che riaccende il caso: «Chiara Poggi aggredita in cucina». La nuova perizia che punta dritto su Stasi
A diciotto anni dal delitto di Garlasco, una nuova perizia commissionata dalla famiglia Poggi ridisegna l’azione omicidiaria. Secondo i consulenti, Chiara Poggi sarebbe stata aggredita in cucina, durante la colazione. Un elemento che riporta al centro Alberto Stasi e mira a frenare ogni ipotesi di revisione del processo.

Il caso Garlasco torna a far discutere con un nuovo colpo di scena. Secondo una recente perizia commissionata dai genitori di Chiara Poggi, l’aggressione che portò alla sua morte non sarebbe iniziata all’ingresso della villetta di via Pascoli, come ipotizzato nel 2007, ma in cucina. Una ricostruzione che cambia la sequenza dei fatti e che, nelle intenzioni della famiglia, rafforza ulteriormente la colpevolezza di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.
Accertamenti tecnici sulla scena del crimine
A firmare l’analisi è il consulente Dario Redaelli, che ha concluso una serie di accertamenti tecnici sulla scena del crimine. «L’aggressione comincia in cucina», spiega il perito, richiamando un elemento noto ma oggi riletto in modo diverso: nella spazzatura dell’ultima colazione di Chiara fu trovato un bricco di Estathé sulla cui cannuccia è presente il Dna di Stasi. Per i consulenti dei Poggi, questo dettaglio colloca il primo contatto violento in un ambiente domestico e quotidiano, incompatibile con l’ipotesi di un’aggressione improvvisa da parte di terzi.
Ipotesi alternative
La nuova perizia si inserisce in un momento delicato. Da mesi, infatti, il caso è tornato sotto i riflettori per le ipotesi alternative emerse nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia, che ha acceso l’attenzione anche su Andrea Sempio. Una pista che la famiglia Poggi ha sempre respinto con fermezza, ribadendo di non avere mai dubbi sulla responsabilità dell’ex fidanzato di Chiara.
Non a caso, questa ricostruzione viene letta come una mossa preventiva rispetto a una possibile richiesta di revisione del processo. Lo stesso Redaelli ammette che i risultati «potrebbero essere utilizzabili» in quel contesto, lasciando però la decisione finale ai legali. L’obiettivo appare chiaro: ribadire una verità processuale che i genitori della vittima ritengono già accertata.
Resta ora da capire quanto questa nuova dinamica potrà incidere sul piano giudiziario. Le conclusioni dovranno confrontarsi con l’esito della nuova analisi delle macchie di sangue affidata al Ris di Cagliari, già consegnata ai magistrati. Secondo indiscrezioni, anche il Ris confermerebbe un’aggressione in più fasi. Il nodo centrale è stabilire se l’inizio in cucina o all’ingresso possa davvero fare la differenza nel quadro complessivo.
A distanza di quasi vent’anni, il delitto di Garlasco continua così a dividere, tra sentenze definitive e nuovi tentativi di rilettura. Per la famiglia Poggi, però, la strada resta una sola: Chiara è stata aggredita in casa, in cucina, e il nome del colpevole non è mai cambiato.
-

 Gossip2 anni fa
Gossip2 anni faElisabetta Canalis, che Sex bomb! è suo il primo topless del 2024 (GALLERY SENZA CENSURA!)
-

 Sex and La City2 anni fa
Sex and La City2 anni faDick Rating: che voto mi dai se te lo posto?
-

 Cronaca Nera2 anni fa
Cronaca Nera2 anni faBossetti è innocente? Ecco tutti i lati deboli dell’accusa
-

 Speciale Grande Fratello1 anno fa
Speciale Grande Fratello1 anno faHelena Prestes, chi è la concorrente vip del Grande Fratello? Età, carriera, vita privata e curiosità
-

 Gossip2 anni fa
Gossip2 anni faLa De Filippi beccata con lui: la strana coppia a cavallo si rilassa in vacanza
-

 Speciale Olimpiadi 20242 anni fa
Speciale Olimpiadi 20242 anni faFact checking su Imane Khelif, la pugile al centro delle polemiche. Davvero è trans?
-

 Video1 anno fa
Video1 anno faVideo scandalo a Temptation Island Spagna: lei fa sesso con un tentatore, lui impazzisce in diretta
-

 Speciale Grande Fratello1 anno fa
Speciale Grande Fratello1 anno faShaila del Grande Fratello: balzi da “Gatta” nei programmi Mediaset


































